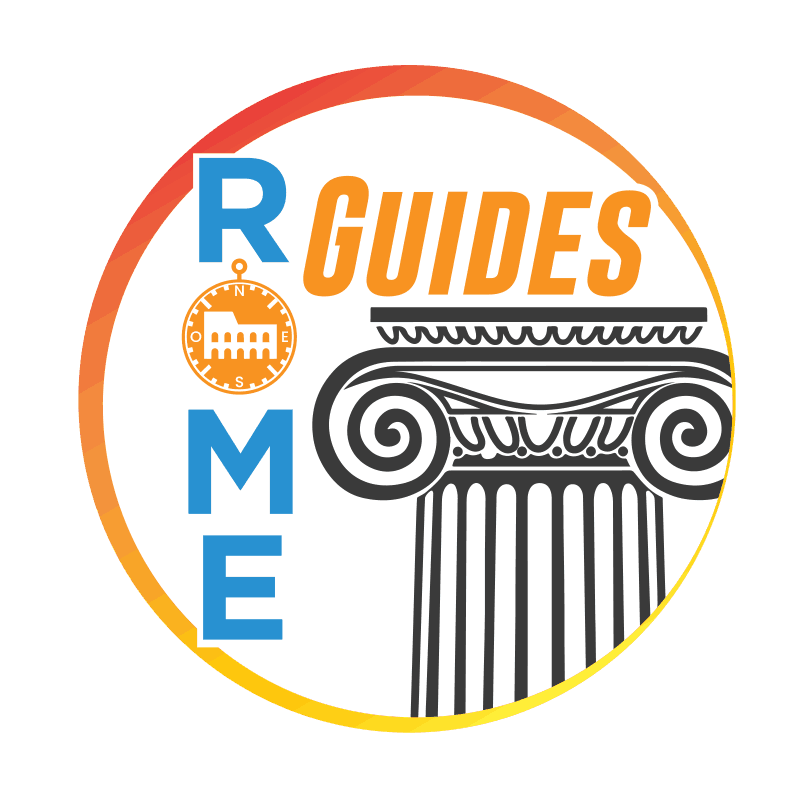LA COLONNA TRAIANA
La Colonna Traiana svetta oggi, come una quinta scenografica, all’inizio di Via dei Fori Imperiali, che da Piazza Venezia conduce al Colosseo. In realtà, però, la grandiosa colonna che doveva celebrare la conquista romani della Dacia era stata concepita da Traiano in modo completamente diverso: non come isolato monumento alle glorie della guerra appena conclusa, ma come approdo di un percorso obbligato attraverso il Foro di Traiano, il più grande che gli antichi Romani abbiano mai costruito (scoprime ogni segreto attraverso il Tour del Museo dei Fori Imperiali, sito all’interno dei Mercati di Traiano).
La Colonna occupava il centro di un piccolo cortile di circa 25 metri per 18 metri, limitato dalla Basilica Ulpia, dalle due biblioteche (greca e latina) e dal colonnato d’accesso al più vasto cortile dove sarebbe sorto, dopo la morte di Traiano (117 d.C.), il tempio a lui dedicato. Tutto il Foro fu pensato sin dall’inizio secondo un coerente e densissimo programma iconografico, il cui tema primo era naturalmente il racconto e la celebrazione delle due campagne daciche (101-102 e 105-106 d.C.), esaltate però anche e soprattutto dal punto di vista dei soldati, per l’impegno militare, il successo della conquista, la disciplina e il valore dei soldati e la ferma conduzione dell’imperatore.
Al Foro (lungo 300 metri e largo 185) si accedeva attraverso un grande arco trionfale, di cui solo alcune monete di Traiano ci restituiscono un’immagine: ai lati dell’unico fornice si aprivano quattro nicchie (due per parte), con statue raffiguranti probabilmente Daci prigionieri. Al di sopra delle nicchie e del fornice c’erano cinque imagines clipeatae (ritratti su scudi), forse di generali; sulla cima dell’arco, tre colossali gruppi di bronzo aventi al centro Traiano incoronato da una Vittoria alla guida del carro trionfale a sei cavalli e, sui lati, due trofei di armi nemiche affiancati ciascuno da due Vittorie.
Oltre l’arco si apriva una piazza vastissima, dominata dalla grandiosa statua equestre in bronzo di Traiano (nota anch’essa dalle monete) e bordata di colonnati dietro i quali si scorgevano due ampie esedre, una delle quali è ancora ben vivibile nell’area dei Mercati di Traiano. Una movimentata decorazione scultorea, fatta di rilievi e statue, era profusa in ogni spazio disponibile, come dimostrano ancor oggi i resti delle statue raffiguranti i Daci prigionieri.
In fondo alla piazza, una breve scalinata articolata attorno a tre ingressi segnava il limite della Basilica Ulpia, imponente edificio biabsidato a cinque navate il cui interno, popolato di oltre conto colonne, era caratterizzato dall’uso massiccio di marmi policromi.
Altre statue e rilievi (fra i quali la grande Battaglia di Traiano contro i Daci che poi, segata in più parti, fu trasportata sull’Arco di Costantino) decoravano il Foro e, come informa Aulo Gellio, “per ogni dove furono ponte statue in bronzo dorato di cavalli e d’insegne militari, e sotto corre la scritta: KX MANUBUS [dal bottino di guerra]”. La stessa Colonna Traiana, sui cui rilievi l’Imperatore Traiano compare quasi sessanta volte, portava in cima una statua bronzea dell’imperatore, la cui ripetuta presenza raffigurava per l’appunto la chiave di lettura dell’intero programma iconografico.
La Colonna Traiana ed il Foro che le sorgeva attorno stupivano anche a distanza di secoli. Ammiano Marcellino, ad esempio, lasciò una breve cronaca del soggiorno a Roma di Costanzo II nel 357 d.C.: “quando arrivò al Foro Traiano, fabbrica senza confronto al mondo, e meravigliosa anche per consenso dei numi, vi rimase a lungo attonito, aggirandosi assorto fra quegli edifici giganteschi che non possono descriversi con parole, né mai più essere anche solo immaginati dai mortali”. L’imperatore in questione, dopo aver esaminato la grandiosità di tali costruzioni, decise di abbandonare ogni speranza di tentare costruzioni di tal mole, e disse che avrebbe semmai imitato a Bisanzio la statua equestre di Traiano posta nel mezzo della piazza; a quel punto però il principe persiano Ormizda, che lo accompagnava, gli rispose argutamente “per alloggiare un cavallo come questo, o imperatore, dovrai prima costruirgli una stalla adeguata”.
Secondo Cassio Dione, l’architetto del Foro era stato quello stesso Apollodoro di Damasco che per Traiano costruì anche le Terme: uomo geniale e versatile, di cui Traiano si servì anche come architetto militare, portandoselo dietro nelle guerre di Dacia e affidandogli la costruzione di un ardito ponte sul Danubio. Del ruolo importante che Apollodoro ricoprì accanto a Traiano sono testimonianza sicura non solo il suo ritratto (conservato alla Gliptoteca di Monaco), l’unico conosciuto di un architetto antico, ma anche alcuni aneddoti tramandati dagli antichi a proposito dei suoi difficili rapporti con Adriano, successore di Traiano, presso il quale cadde rapidamente in disgrazia.
Il Foro Traiano fu costruito vicino agli altri Fori, innalzati dai predecessori di Traiano, da Cesare a Nerva; poiché non esisteva in quella zona un’area pianeggiante adeguata alla grandiosità del progetto, si provvide a crearla eliminando la cresta che univa il Campidoglio al Quirinale, con una titanica opera di sbancamento. Lanciani ha calcolato che dovettero essere espropriati circa 90,000 metri quadrati, occupati da edifici privati o pubblici; quanto all’altezza dello sperone che fu eliminato, è la stessa iscrizione sul basamento della Colonna a darne notizia, essendo essa alta quanto il mons che sorgeva prima in quell’area.
Prodigiosamente completato in soli sei anni (dal 107 al 113 d.C.), il Foro doveva essere ancora in piedi nell’VIII secolo, come sembra indicare l’anonimo autore dell’Itinerario di Einsiedeln, ma nel Medioevo l’area fu profondamente rimaneggiata e vi furono costruiti due monasteri e almeno sette chiese, certamente riutilizzando in parte le strutture esistenti. Le antiche funzioni amministrative e di rappresentanza di quest’area monumentale tramontarono per sempre e, una volta trasferito al Papato l’onere della manutenzione degli edifizi già fatiscenti, il miglior modo di provvedervi fu di installarvi monaci e chiese. Tra l’altro, l’occlusione delle cloache per mancanza di manutenzione aveva provocato la formazione di una zona paludosa, che deve aver meritato il suo nome di “Pantani”.
Dopo i danni subiti nel Sacco di Roma del 1527, un primo rimaneggiamento della zona del Foro Traiano si ebbe sotto Paolo III Farnese, in occasione della visita a Roma di Carlo V durante la Pasqua del 1530: in quell’occasione si cominciò a demolire anche la chiesa di San Nicola de Columna, e lo stesso Papa, con un breve del 1540, autorizzò i cavapietre ad asportare i marmi del Foro per la Fabbrica di San Pietro.
Verso il 1570, il cardinale Michele Bonelli cominciò a bonificare i Pantani, e l’area dei Fori venne progressivamente urbanizzata, creando un piccolo quartiere che resterà inalterato fino al 1931, quando i grandi e frettolosi sterri voluti da Mussolini diedero alla zona l’aspetto odierno.
LA COLONNA TRAIANA
In questa storia contraddistinta più da distruzioni che da analisi archeologiche, la Colonna Traiana fa storia a sè: se del Foro di Traiano, come insieme monumentale, si perse infatti presto coscienza e memoria, la Colonna, al contrario, fu costantemente conservata e protetta.
Gli elenchi dei monumenti di Roma dell’epoca (come il Curiosum e la Notitia Urbis), pur senza effettuarne un’analisi dettagliata, ne ricordano alcune curiosità: l’altezza (indicata variamente da 127 a 144 piedi), il numero dei gradini della scala interna (180 o 185), il numero delle piccole finestre che la rischiarano (45) e, soprattutto, il fatto che le ceneri di Traiano fossero state deposte in un’urna d’oro nel basamento stesso della Colonna, come indicato persino da San Girolamo. La salita dentro la Colonna, fino alla terrazza che si apre ancor oggi in cima al capitello, deve essere sempre stato un privilegio rarissimo per gli illustri visitatori di Roma: dovette fra gli altri l’imperatore d’Oriente Costante II, giunto a Roma nel 667 assieme ai suoi dignitari, uno dei quali appose la sua firma sulla parete della scala.
Tutti vollero sempre salvaguardare la memoria storica di un simile nobile passato: in un documento datato 27 marzo 1162, i Senatori di Roma dichiararono solennemente che “per l’onore di tutto il popolo romano, la Colonna non dovrà essere mai danneggiata da alcuno, ma restare così com’è, integra ed incorrotta, finché il mondo duri”, connettendo ad ogni possibile attentato alla sua integrità la pena di morte e la confisca di ogni bene dell’eventuale vandalo.
In molti, in realtà, apparvero confusi su chi la avesse eretta, quantomeno nei secoli bui del Medioevo. Boncompagno da Signa, giurista dello Studio bolognese, ricordava la Colonna nel suo Liber de obsidione Anconae (1201) dicendola costruita da Adriano, e lo stesso fece nella metà del Quattrocento il patrizio fiorentino Giovanni Rucellai, che la definì “facta per Adriano imperadore in luogo d’uno arco trionfale, la quale è di marmo storiata della vectoria ch’egli ebbe”.
Il vero studio della Colonna Traiana iniziò in realtò solo quando gli artisti ebbero modo di cominciare a ricopiarne le scene a bassorilievo. Ai primi del Cinquecento, il bolognese Jacopo Ripanda disegnò per primo tutta la Colonna, facendosi calare dall’alto del capitello sospeso dentro un cestone: nacquero proprio da questa eroica impresa tutti i libri a stampa che riprodussero con incisioni l’intero fregio della Colonna, a partire da quello curato da Girolamo Muziano nel 1576. A ciò si aggiunsero i calchi, con un primo progetto (mai realizzato) commissionato da Francesco I, un secondo promosso nel 1665 da re Luigi XIV e soprattutto il più celebre di tali lavori, organizzato nel 1861 dal sovrano francese Napoleone III, da cui derivano anche i calchi del Victoria and Albert Museum.
La Colonna di Traiano, quinta di scenario o rudere da animare narrava lo straordinario successo militare riportato contro i Daci, un antico nemico di Roma, a cui l’Imperatore Domiziano era stato persino costretto a versare un tributo e che invece adesso veniva ad essere travolto dagli eserciti dell’Impero Romano e ridotto a sudditanza, rendendo alfin sicuro il confine del Danubio. Fu al termine di questo lungo conflitto che i Romani poterono recuperare l’agognato bottino, l’immenso tesoro del re sconfitto Decebalo, acquisendo le miniere d’oro e d’argento già usate dai Daci.
Si era conclusa, insomma, una delle più fortunate spedizioni militari dell’intera storia di Roma: Traiano, che aveva personalmente condotto le operazioni di guerra spostandosi da un luogo all’altro della Dacia, sembrava dunque restituire senso e dignità all’antico titolo repubblicano di Imperator, che aveva designato in origine i generali vittoriosi e meritevoli, per decreto del Senato, di celebrare il trionfo, ma era poi toccato a tutti i successori di Augusto, anche i più imbelli.
Di certo i suoi contemporanei lo esaltarono quale Optimum Princeps, mentre possono immaginarsi scritti con linguaggio ben più asciutto quei Commentarii in cui lo stesso Traiano, modellandosi sul De Bello Gallico di Cesare, narrò le guerre daciche (ne è conservato un solo breve frammento). Di tutta quell’immensa produzione letteraria ben poco ci è rimasto, ma quel poco (nelle parole di Plinio) è sufficiente per comprendere come Traiano fosse decisamente inserito in modo perfetto all’interno delle sue truppe. Nel suo Panegirico lo scrittore dichiara: “Gli altri entravano in città non dico su trionfale quadriga, ma persino a spalle su una portantina. Tu camminasti fra noi, sormontandoci solo per l’altezza naturale del tuo corpo, e così hai trionfato non sulla nostra arrendevolezza, ma sulla superbia degli altri imperatori. Perciò le strade erano stipate di folla, e a te non restava libero che uno stretto passaggio in mezzo al popolo esultante e acclamante. Per tutti sei venuto, e tutti ne abbiamo tratto una gioia che cresceva d’intensità quasi a ogni tuo passo. Né ti eri circondato di guardie, ma avanzavi a passo lento e calmo, consentendo con piena fiducia che chiunque ti si avvicinasse. Infine, ti recasti al Palazzo, ma col volto e la modestia di chi andasse verso la propria casa privata”.
Nella lunga trama decorativa della Colonna Traiana, minuziosamente elaborata dal Maestro della Colonna, gli ingredienti erano principalmente due. Da un lato c’era ovviamente la trama stessa degli eventi della prima (101-102) e della seconda guerra dacica (105-106 d.C.), estratta probabilmente dai diari di Traiano ma che il pubblico contemporaneo comunque ben conosceva sia per diretta testimonianza di reduci che grazie alla solenne celebrazione delle vittorie che si era tenuta in Roma alla fine di ciascuna campagna. Dall’altro lato c’era però un ingrediente specificamente iconografico: le pitture trionfali che, per lunga e solidissima tradizione, almeno dal III secolo a.C. presentavano al popolo romano, dopo ogni guerra vittoriosa, una sorta di compendio degli eventi, centrato sulla descrizione dei luoghi e sulla narrazione delle battaglie: esposti sulle pareti esterne della Curia, questi grandi quadri su tavola erano suddivisi in scene in grado di trasportare sul campo di battaglia tutti gli osservatori, sostanziando il racconto nelle immagini. In tal senso, i rilievi della Colonna Traiana altro non sono che la trasposizione in marmo di tale pittura trionfale.
IL RACCONTO DELLA COLONNA TRAIANA – PRIMA PARTE
La Colonna Traiana parla con grande eloquenza: ogni battaglia, ogni ambasceria, ogni marcia è diversa da ogni altra, ma la formula iconografica del racconto storico è lineare ed uniforme. Esaminando i singoli pannelli, visibili anche (nella speranza di una prossima riapertura) presso il Museo della Civiltà Romana all’EUR (contattaci per un tour del meraviglioso quartiere EUR), è possibile ricostruire, per così dire, il taccuino del Maestro della Colonna, nei cui appunti è possibile leggere la narrazione delle due guerre daciche.
Di sfondo spicca il paesaggio, tra fortini con torce accese e limes danubiano, in cui le notazioni topografiche animano e caratterizzano lo sfondo delle scene, indicando talvolta le impervie regioni dove i Daci col loro bestiame vanno a rifugiarsi dopo la fine della prima guerra (scena 76) e talaltra mostrando cinte d’assedio le lunghe mura della capitale dacica Sarmizegetusa, innalzata su basamenti di roccia (scena 114).
Anche gli edifici compongono la scena, caratterizzando lo spazio urbano di una città romana sul Danubio dove Traiano sacrifica un toro (scena 80), mentre il castrum romano davanti al quale un Dace si arrende a Traiano è compendiato in una breve cinta muraria (scena 60). Il Danubio viene raffigurato molteplici volte, in particolare nella scena d’apertura, dove il torace del fiume-dio coronato di canne propizia, emergendo fra le rocce, il passaggio di due file di soldati romani carichi d’insegne sopra due munitissimi ponti di barche. È lo stesso grandioso fiume che viene “sconfitto” dal corpus fabrorum (il genio militare), che vi edifica sopra il grandioso ponte progettato da Apollodoro di Damasco (scena 98).
Gli sfondi, pertanto, non solo ambientano le singole scene, ma si propongono come una sorta di colorito itinerarium pictum, che accompagna l’avanzata dell’esercito romano e che fa pensare come probabilmente una parte del Commentarius potesse essere stata riservata alle descrizioni e notazioni geografiche.
Se lo sfondo cambia di continuo, le scene ed i personaggi si ripetono con relativa costanza. Come detto, Traiano compare sulla Colonna poco meno di sessanta volte, e accanto a lui riconosciamo pochi comites; nel campo opposto, è possibile attribuire un nome al solo re dei Daci, Decebalo. In ogni caso, soprattutto fra i legionari si vedono visi ben caratterizzati: i legionari con la corazza segmentata e gli ausiliari con il corpetto di cuoio, contrapposti ai Daci, col berretto in testa e le lunghe chiome, sono contraddistinti da volti ed abiti diversi.
Lo sguardo del pubblico contemporaneo era in ogni caso chiamato soprattutto a riconoscere le insegne delle legioni, distinguendole l’una dall’altra. In questa storia collettiva, la rappresentazione non sarebbe ovviamente stata possibile senza effettuare una congrua e simbolica riduzione dei numeri: le molte migliaia di soldati romani che attraversano il Danubio possono esser mostrati solo se ridotti a un drappello di poche decine, e per di più quasi tutti portatori delle insegne (scena 4): in tal senso, spesso una sola figura rappresenta una legione intera.
A questa norma necessaria sfugge tendenzialmente solo la figura di Traiano, che non solo non è “riducibile” ma che anzi condensando nel suo volto tutto il potere, divenendo un simbolo più che un individuo: il ruolo del Princeps e le virtù personali di Traiano si confondono così in una sola aura, quasi divina ed in ogni caso destinata a grandi imprese eroiche.
Otto volte, nella Colonna, Traiano si confronta col suo esercito parlando a una piccola folla di soldati dall’alto di un piedistallo: queste scene di adlocutio sono tutte costruite secondo uno schema identico, sempre riconoscibile e però sempre variato nei singoli dettagli. L’imperatore viene rappresentato accompagnato da due alti ufficiali, mentre solleva verso il suo pubblico il braccio destro in un gesto di eloquenza, con i soldati che lo ascoltano intenti e compatti.
Altrettanto frequenti sono le scene che presentano lavori di costruzione di castra, di disboscamento o di approntamento di strade: si tratta delle tradizionali opere che segnano visibilmente la romanizzazione del territorio e ne garantiscono percorribilità e difesa. Il grande rilievo che questi temi assumono nella trama della Colonna assicura la loro importanza per il popolo romano, ed è perciò naturale che lo stesso Traiano compaia sull’alto delle mura, sempre coi suoi comites, come a sovrintendere ai lavori (scene 11-12). Qui la moltitudine dei fabri militari è suggerita non addensandoli fianco a fianco come nelle scene di adlocutio, ma invece dando risalto, e quasi monumentalità, al lavoro di pochi: i dodici soldati in corta tunica che abbattono alberi e costruiscono una strada al principio della seconda campagna (scena 92) vogliono perciò rappresentare l’immenso e rapidissimo operare di centinaia di compagni.
In questa che è soprattutto la narrazione di una guerra, sono relativamente poche le scene che rappresentano propriamente una battaglia o un assedio: circa una dozzina, sui duecento metri di sviluppo lineare del fregio figurato. In tal senso, le operazioni belliche in senso stretto sono presentate così come una parte importante, ma non esclusiva della conquista della Dacia. La Colonna Traiana non mostra quindi che una scelta delle battaglie delle due campagne daciche, tra l’altro obbligatoriamente ridotte nelle proporzioni in virtù delle regole artistiche fin qui precisate. Il cozzo fra i due eserciti è presentato spesso mediante lo scontro degli scudi secondo una diagonale che segue il ritmo ascensionale del fregio; intorno a questa linea si dispongono le schiere degli armati, addensandosi qua e là in duelli individuali o di piccoli gruppi. La prima grande scena di battaglia (24-25) mostra un’immobile schiera di legionari pronta a intervenire, in evidente ostentazione di muta presenza e di tensione al combattimento.
Poco dopo Traiano, fra due ausiliarii e un comes, accoglie i primi che tornano dalla battaglia in corso, mostrandogli le teste appena tagliate dei nemici uccisi quale sanguinoso trofeo foriero di vittorie: il Princeps non solo quindi dirige le operazioni militari, ma constata con serenità l’inevitabile vittoria. Più avanti fuggono i Daci, con due di loro che soccorrono un giovane ferito, mentre da un piccolo bosco sullo sfondo emerge il volto del re Decebalo. Nel frattempo, però, compare nel cielo, fra i combattenti e il bosco, la figura di Giove che scaglia il fulmine contro i Daci manifestando il favore divino per l’impresa dei Romani e prefigurando l’esito non di questa prima battaglia, ma della guerra intera.
L’albero sotto il quale compare Decebalo segna il confine con la scena successiva (scena 25), dove Traiano è atteggiato come in una adlocutio, ma davanti a sé non ha la folla intenta dei soldati: egli sovrasta anzi una città dei Daci, messa a ferro e fuoco dai Romani, mentre un gruppo di Daci sembra essere messo in fuga dalla sua sola presenza.
Il favore degli dei e la continua presenza di Daci caduti (in tutta la Colonna non è mai rappresentato un solo Romano morto in battaglia!) tracciano le coordinate di un discorso che non è dunque meramente narrativo, ma rappresentativo di un’avanzata inarrestabile, di una vittoria che nessuno può contrastare. I Daci sono presentati come un nemico nobile e altero, che non si piega facilmente e che combatte duramente fino all’ultimo; proprio per questo motivo, la vittoria dei Romani e di Traiano si prevede essere ancor più gloriosa.
Altre volte, alcuni Daci compaiono davanti all’imperatore in scene di cattura o di ambasceria. Uno dei Daci, catturato sull’inizio della prima campagna, è trascinato davanti a Traiano da un ausiliario che lo afferra per i capelli e per le mani legate dietro la schiena, e col ginocchio lo colpisce nel cavo dell’anca, obbligandolo a piegarsi davanti al principe (scena 18). Un gruppo di ambasciatori dai lunghi mantelli frangiati discorre con Traiano gesticolando, mentre tutt’intorno legionari trasportano materiali da costruzione (scena 52). Un pileatus, forse appena catturato, viene ad arrendersi gettando a terra il suo scudo e inginocchiandosi davanti all’imperatore con le braccia levate nel gesto del supplice (scena 61). La figura di Traiano è sempre accresciuta grazie ad un ampio gesto solenne, che lo stacca nettamente dagli altri due Romani, mostrando in lui la sola meta degli ambasciatori Daci, il solo che prenderà decisioni.
La stessa aura di onnipotenza di Traiano spicca quando, in abito sacerdotale e col capo velato, effettua sacrifici agli dei, circondato da numerose figure strette attorno all’Imperatore. Anche quando Traiano, ritto sulla prua di una nave che attraversa l’Adriatico, batte il tempo ai rematori, la composizione è costruita in modo da far convergere su di lui l’attenzione: la sua nave è fiancheggiata da altre due, e verso Traiano si volgono, in alto e in basso, i due personaggi ritti sulle prore (scena 79).
Decebalo, in realtà, funge da contraltare dell’Imperatore. È il re dei Daci a sostare, all’inizio della seconda campagna, all’ingresso di un fortino dove i barbari accorrono forsennatamente (scena 93); è sempre lui ad osservare da un rialzo roccioso il tentativo del proprio esercito di prendere d’assalto un castrum romano strenuamente difeso dai legionari. Questo artifizio compositivo, che fa risaltare il ruolo di Decebalo quale contraltare di Traiano, si traduce in un quasi cavalleresco riconoscimento del valore del re nemico, definito da Cassio Dione “un antagonista degno dei Romani”.
Solo allo scopo di riassumere in poche righe il lunghissimo ed elaborato fregio della Colonna Traiana, è possibile chiarire che quest’ultimo indica innanzitutto la successione degli eventi nel tempo e l’avanzata dell’esercito nello spazio, esaltando però in un ciclo continuo la vittoria delle armi romane e la virtus personale dell’imperatore, in uno specchio assai ben lucidato del rapporto esistente fra il Princeps e l’esercito. Non sbagliò Costantino quando, duecento anni dopo, prelevò da un monumento di Traiano il grandioso rilievo con battaglia contro i Daci e lo inserì nel proprio arco trionfale (dov’è ancora): non si trattò di furto, ma bensì dell’affermazione del perpetuo destino di vittoria che non arrideva specificamente a Costantino o a Traiano, ma che si riferiva in generale a Roma ed al suo Imperatore.
IL RACCONTO DELLA COLONNA TRAIANA – SECONDA PARTE
È un’immobile Vittoria alata scrivente su uno scudo, assai diffusa in simili decorazioni trionfali, che divide le due campagne l’una dall’altra, a metà della spirale (scena 78). La prima campagna si era aperta mostrando sentinelle in armi sulle rive del Danubio, e poi il passaggio degli eserciti romani su ponti di barche (scena 4). La prima comparsa di Traiano è sopra un alto podio, dove siede un consiglio di guerra; segue quasi subito il primo sacrificio, e poi la prima adlocutio e la prima scena di costruzione (scene 11-12), a cui Traiano stesso presiede. Ecco quindi il primo incontro con un prigioniero Dace (scena 18): così quasi l’intera tipologia delle scene è subito dispiegata. La grande battaglia delle scene 21-25, dominata da Giove e da Traiano, è probabilmente quella di Tapae, nota dalle fonti letterarie; nelle scene che seguono torna da protagonista il Danubio, che i Daci in rotta tentano invano di attraversare (scena 31).
Poco dopo, altre scene di battaglia: cavalieri romani inseguono nemici dalle singolari corazze a squame che coprono anche il corpo dei cavalli (i cosiddetti catafratti), mentre medici militari romani curano alcuni feriti. In mezzo a tante scene più abituali, spiccano ogni tanto temi più rari: Traiano che distribuisce donativi ai soldati valorosi, acclamato dall’esercito, con accanto la scena inesplicabile di donne che torturano col fuoco alcuni prigionieri nudi (scena 45). Si susseguono ambascerie (scena 52), costruzione di strade (scena 56), resa di Daci (scena 61), battaglie e teste mozzate di nemici, fino alla grande scena di resa che segna il termine della prima campagna (scena 76), con l’adlocutio finale tenuta da un Traiano già pronto a mettersi in viaggio (scena 77).
La seconda campagna si apre con un lungo viaggio di Traiano verso il teatro della guerra: prima l’attraversamento dell’Adriatico (scena 79), poi soste e sacrifici in varie città sulla strada (scena 86), ancora un tratto di mare (scena 87) ed infine l’incontro coi Daci già sottomessi e fedeli ai Romani (scena 90). Si costruiscono, ancora, strade fra i boschi (scena 92), mentre i Daci guidati da Decebalo si raccolgono nelle loro fortezze (scena 93). Traiano sacrifica davanti al gigantesco ponte che il suo architetto Apollodoro di Damasco ha edificato sul Danubio per consentire un più rapido passaggio delle truppe (scena 98), e proseguono assedi e battaglie fin sotto le mura della capitale di Decebalo, Sarmizegetusa (scena 114).
L’incalzare dei Romani lascia ormai poche speranze ai Daci; e in una grande, concitata scena che non ha né precedenti né paralleli in tutta l’arte antica, una moltitudine di Daci entro le chiuse mura di un forte si uccide attingendo il veleno da un vaso, dispiegando in gesti ora solo rassegnati ora parossistici la gamma di ogni disperazione, mentre alcuni fuggono nei boschi in preda al terrore (scena 121). Si raccoglie, tuttavia, l’ultimo tentativo di resistenza, e Decebalo sorveglia l’attacco a un castrum romano, ma invano: un contingente della cavalleria romana raggiunge quindi il capo dei Daci, ingaggiando un combattimento, e mentre ormai sta per afferrarlo un cavaliere romano (le cronache raccontano che si chiamasse Tiberio Claudio Massimo), Decebalo riesce a sfuggire alla cattura tagliandosi la gola con un coltello ricurvo (scena 145).
Intorno al re sconfitto, al nobile antagonista, si stringono da presso i Romani balzando giù dai cavalli, e gli fanno corona dai due lati: un’ultima volta il suo rango e la sua condotta valorosa gli meritano un’aura di attenzione sapientemente costruita, poiché più forte è il nemico, più grande è la vittoria.
—
Se l’articolo del nostro blog vi fosse piaciuto, potreste decidere di partecipare ad una delle visite guidate organizzate dall’Associazione Culturale Rome Guides. Contattateci per creare l’itinerario perfetto per le vostre richieste.